

Un percorso diacronico sul rapporto tra le donne veneziane e la giustizia. Alessandra Schiavon, Anna Bellavitis e Nadia Maria Filippini hanno raccolto in un volume edito dall’Ateneo Veneto (CCXL, 23/1 (2024) storie di battaglie e conquiste tra «dissimmetrie legislative e casi di agency femminile» dal Medioevo all’età contemporanea. Studiose provenienti da ambiti diversi hanno approfondito le disparità nella legislazione, evidenziando come normative civili, penali, sociali e politiche abbiano codificato privilegi e diritti asimmetrici a favore degli uomini e come, parallelamente, le donne abbiano cercato di ritagliarsi spazi di libertà. «Venezia è da sempre un laboratorio di innovazione e tradizione», osserva Gianmarco Guidarelli nell’introduzione, «ed oggi è il miglior contesto possibile dove riflettere ed elaborare criticamente le contraddizioni e le sfide della modernità». Il volume è consultabile qui.

Nell’inverno 1324 Marco Polo, ormai anziano e malato nel suo letto veneziano, decice di dettare il suo testamento al notaio Giovanni Giustinian. Con voce debole ma decisa, il viaggiatore divide le sue fortune tra le tre figlie Fantina, Bellella e Moretta. Il marito della prima, Marco Bragadin, non tarda a prendere in mano le redini dell’eredità della moglie. Non solo s’impadronisce della parte che le spetta, ma si rifiuta di render conto della gestione patrimoniale. Alla sua morte nel 1360, Bragadin lascia una lunga lista tra debitori e beni da spartire in cui non figura il nome della moglie. Fantina, sola e determinata, non accetta questa ingiusta esclusione. Nel 1361, intraprende un’azione legale contro il marito defunto, rivendicando il suo diritto a gestire l’eredità del padre. La contesa legale tra la donna e i Procuratori di San Marco si conclude nel 1366. Fantina viene chiamata a supportare la sua testimonianza con prove documentarie accumulate nel tempo. E lei provvede, senza esitazioni: oltre al testamento paterno, esibisce di fronte ai giudici una grande quantità di carte, che attestano tutti i tentativi vani esperiti nel corso degli anni per raggiungere un accordo con il coniuge. «Alla strada del silenzio e della resa», riflette l’autrice Alessandra Schiavon, «Fantina ha preferito quella giustizia, sebbene lunga ed accidentata».
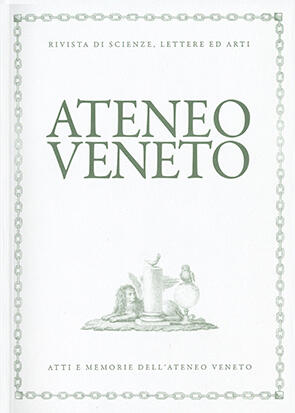
A metà Settecento, le donne veneziane sono grandi frequentatrici dei caffè: si appropriano con naturalezza di questi spazi che, altrove in Europa, sono di dominio esclusivo degli uomini. Questo nuovo protagonismo femminile scuote le fondamenta di un assetto sociale che il governo della Serenissima teme di veder compromesso. Questo nuovo protagonismo femminile scuote le fondamenta di un assetto sociale che il governo della Serenissima teme di veder compromesso. Nel 1699, le autorità prima impongono la rimozione di banchi e sedie esterne per impedire la permanenza prolungata dei clienti e poi la chiusura a mezzanotte. Ma i provvedimenti hanno scarso effetto. Nel 1766, gli Inquisitori ordinano lo smantellamento dei camerini. I caffettieri sono obbligati a fornire descrizioni dettagliate delle opere di adeguamento e a sottoporsi ad ispezioni per verificare il rispetto delle disposizioni. Il 28 gennaio 1777, il Consiglio dei Dieci prende una decisione drastica: vieta l’ingresso delle donne in tutti i caffè della città. La misura scatena una vera e propria rivolta. Le donne trasgrediscono deliberatamente al divieto e i caffettieri danno loro man forte mettendo a punto i più diversi espedienti: dalle semplici petizioni all’organizzazione di spazi separati. Si arriva così ad un compromesso: l’accesso è consentito solo per rifornirsi di acquaviti e liquori, senza consumare caffè o sedersi. La città non tollera la separazione imposta e l’impopolarità del decreto lo rende presto inefficace. «A Venezia la sfera pubblica è intrisa di socievolezza e del desiderio di mescolamento fra ceti e soprattutto tra generi», osserva Tiziana Plebani, «la visibilità delle donne, colta anche dallo sguardo dei forestieri, compone ormai l’immagine della città così come ci si aspettava e si voleva che fosse ed era indistinguibile dai suoi spazi, dai suoi ritrovi, dalla sua scena pubblica».

Per le donne veneziane, il testamento non si riduce unicamente ad un atto di disposizione delle proprie volontà, ma si rivela uno strumento di difesa e riscatto. Nei documenti emergono frammenti di vita nascosti come come ultime volontà: vere e proprie dichiarazioni di autonomia e resistenza contro le ingiustizie. «Per ricostruire una biografia femminile o ottenere informazioni sulla condizione femminile nella Venezia della prima età moderna – un’epoca per la quale mancano, o ci sono pervenuti in misura molto limitata, documenti privati come diari o epistolari -», osserva Federica Amborsini, «il testamento costituisce una delle fonti più preziose». Nei documenti del tempo, non è raro imbattersi nella consuetudine del passphrase: formule specifiche, spesso versetti biblici o preghiere, inseriti nei testamenti per dare forza e garanzia legale al documento. Un escamotage simbolico ed astuto che viene tramandato di donna in donna attraverso il passaparola. Lucieta Vitturi, quando scrive il suo testamento, non si limita alla dichiarazione dei beni, ma include il versetto 16 del Salmo 51: «Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, et exsultabit lingua mea iustitiam tuam». Dalle parole, che invocano la giustizia divina, trapela un chiaro appello contro le persecuzioni di cui si sente vittima. Non sempre, però, la redazione nasce un atto di pura espressione volontaria. Nella società veneziana, molte donne si trovano a subire pressioni familiari e sociali. Camilla Girardi, ad esempio, annulla ciò che il marito le impone di redigere, rifiutando di accettare la volontà imposta. «La postuma soddisfazione della denuncia e l’uso del testamento come arma difensiva è tutto ciò che resta ad altre testatrici», conclude Ambrosini, «donne le cui esistenze sono state devastate in modo ormai irreparabile: a nulla si può più porre rimedio, nulla più si può revocare. A distanza di secoli, le loro voci dolenti, ferite, deluse, tradite hanno ancora il potere di commuoverci».
C.I.D. s.r.l. Società a Socio Unico – Casa editrice del settimanale Gente Veneta – CF e PI 02341300271 – REA: VE – 211669 – Capitale Sociale 31.000 euro i.v. – Dorsoduro,1 – 30123 Venezia
Iscriviti a VE-NICE e non perderti nessun aggiornamento, ti invieremo 1 volta a settimana i nuovi articoli!